Esistono cose che non possono avere nessun altro interesse se non quello personale: il paradosso è che, per quanto semplici o banali, sono le più importanti.
Sono stati i tre anni, quelli immediatamente dopo la Laurea Specialistica.
A quei tempi lavoravo per una piccola azienda, il cui titolare, il tipico cinquantenne emiliano ruspante e borioso, era bravissimo nel rendersi straordinariamente simpatico sul momento per poi trasformarsi nell'essere più spregevole del mondo, uno con cui non si sarebbe più potuto negoziare nemmeno la pausa caffè. Potrei riempire biblioteche d'Alessandria senza aver esaurito gli improperi da rivolgergli.
Come idea: presente la kill list di Arya Stark?
Ebbene, lui sarebbe al primo, al secondo e al terzo posto.
Daje Arya!
Scelse male quando investire e, complici le vendite scarse e il servizio che spesso disattendeva le aspettative dei clienti, cominciò ben presto ad andare in malora e a non avere più gli sghei per pagare i dipendenti. Chi non si dimetteva veniva costretto ad allontanarsi, mentre chi rimaneva veniva lavorativamente sfruttato oltre ogni dire. Portare pazienza era solo un modo più elegante di prenderla nel culo.
Sebbene lavorassi in ufficio, con la carenza del personale la scala del pollaio si fece corta e fui costretto a cimentarmi nei più svariati ruoli, non ultimo quello di trasportatore. Non essendoci più la liquidità per saldare il conto dei corrieri, anche gli impiegati dovevano salire su camioncini, ducati e furgonati e trasportare la merce nelle città e nelle regioni in cui erano presenti ditte che ancora compravano materiale.
Il titolare aveva stabilito che i maggiori carichi andassero effettuati di venerdì (quando non sarebbe cambiato niente fare la stessa cosa di lunedì, ma andarglielo a spiegare era inutile), senza badare al fatto che per raggiungere le Marche o il Veneto si sarebbe passati dagli snodi di Bologna. Cosa anche fattibile, non fosse che nove volte su dieci il materiale non era mai pronto prima di mezzogiorno, per cui tutto diventava enormemente complicato, per non dire impossibile, dovendo attraversare i raccordi bolognesi proprio negli orari di punta nei giorni peggiori in assoluto. Quando invece i carichi non erano eccessivi e le distanze non erano così lunghe, poteva apparentemente filar tutto liscio; tuttavia non accadeva quasi mai, interveniva sempre una causa di forza peggiore a rovinare i piani, anche quelli meglio congegnati.
Le prime volte vivevo questi viaggi come delle piccole avventure, mi piaceva togliermi dall'ufficio, fermarmi in autogrill, vedere posti nuovi e ascoltare parlate diverse. Poi cominciai a non reggere più il dover partire tutti i venerdì pomeriggio, fare tutto di furia, incolonnarmi per ore al ritorno, sacramentare come un pazzo e rodermi il fegato senza nemmeno un grazie o una telefonata dal titolare per sapere se fosse tutto ok. Le sere prima delle trasferte le passavo in bar con gli amici a sbronzarmi e con un'angoscia che mi divorava dentro come una tenia, le mattine successive speravo sempre che succedesse qualcosa per cui non fossi costretto ad andar via, una labile speranza che inevitabilmente andava disillusa allo scadere degli ultimissimi minuti, verso la mezza, quando, se tutto fosse andato come m'auguravo, sarei andato a pranzo a casa. Avrei rimandato il problema, vero, ma almeno non avrei dovuto fronteggiarlo direttamente.
Invece no, invece niente: partivo col camioncino poco prima dell’una. Buon viaggio e tanti saluti.
Una tristezza invincibile
Quando la casualità della trasferta divenne sistematica, decisi, tenendo la cosa al nascosto di tutti, di chiedere a mio padre se volesse sedersi di fianco a me in quelle "gite fuori porta". Un po' perché mi tenesse compagnia (infatti da quei furgoni erano state tolte anche le radio) e un po' perché cominciavo ad accusare lo stress e una persona cara mi sarebbe stata d'aiuto. E poi è assolutamente vero che nella vita è più importante la persona con cui vieni di quella con cui vai, ma c’è sempre l’eccezione che conferma la regola.
Forse non vale la pena né la penna, seppur virtuale, di provare a raccontare quei viaggi, che nemmeno ricordo così bene. Ma è forte la memoria delle sensazioni, come se queste non si fossero mai sopite del tutto. Ed è molto strano perché, in realtà, la mia mente ha fatto selezione dei ricordi legati a quel periodo, quasi se ce ne fossero alcuni da cancellare di netto, spazzare via a mo’ di necessaria terapia per vivere meglio.
Quando mi sveglio e non mi ricordo cos'è successo negli ultimi anni.
Quando mi sveglio e non mi ricordo cos'è successo negli ultimi anni.
Per esempio ho dimenticato completamente l’utilizzo e il significato di alcune parole che invece usavo regolarmente in quei tre anni di lavoro. Quando qualche tempo fa un amico ha pronunciato “dima” è stato come se avesse scaravoltato i file dei miei archivi mentali. Se ci si pensa a modo, si realizza che non è una cosa così comune perché dimenticare è cosa diversa da non ricordare, la prima deriva -per forza- da un'intenzione (magari inconscia o inconsapevole), la seconda può essere anche solo contingenza.
Essere "in dima"
Quei viaggi con mio padre sono invece rimasti nel mio bagaglio emozionale e li riscopro ogni volta che mi metto in autostrada o ogni venerdì alle sei quando, ancora oggi a distanza di ormai quattro anni, non mi sembra vero di chiudere la porta dell’ufficio e aver la consapevolezza che, per tre sere e due giorni, nessuno avrà null’altro a pretendere da me.
LOMBARDIA
Postcards from Italy
La Brianza ha un suo perché. Avrà anche molti “perché no” ma non è poi così male, specie in Primavera quando una natura rigogliosa lascia immaginare le ville che prova a nascondere: insomma, un insolita e incantevole campagna nel bel mezzo dell’industriosa Lombardia.
Capitava spesso di andar dalle parti di Arcore e di Lesmo perché in quei dintorni sono storicamente presenti molte aziende del settore cuciniero.
Al "Nord" non si andava di venerdì ma fra la settimana e ad orari abbastanza ortodossi. Oltretutto il percorso era migliore di ogni altro perché, al netto di qualche imprevisto sulle tangenziali di Milano, la trasferta risultava quasi sempre agevole. Tuttavia, proprio perché c’era sempre un fattore negativo che si frapponeva tra me e i miei geniali progetti di consegna, io e mio padre non riuscivamo mai ad arrivare presso le ditte dove scaricare il materiale, prima che i dipendenti delle stesse si fermassero in pausa pranzo.
Succedeva allora che ne approfittassimo per mangiare un boccone in attesa che riaprissero i cancelli. Ricordo una pessima pizza mangiata alla veloce, della quale avevamo elemosinato buona parte ad un povero vuccumprà che avrebbe ammazzato anche solo perché gli lasciassimo finire le croste. Ne ho memoria come di una delle peggiori pizze mai viste fare sotto i miei occhi e mai assaggiata, per cui in definitiva fummo anche contenti di regalargliene metà.
Un’altra volta dissi a mio padre di trattenersi in un bar, di comprare qualche panino e di aspettarmi mentre io effettuavo la consegna. Al ritorno non lo trovai più e fu una delle mezzore più agoniche della mia vita. Dopo aver recitato quello che non stento a definire l'ideale rosario di madonne (roba che nemmeno Germano Mosconi) e aver assunto comportamenti psicotici che avrebbero svergognato un tarantolato qualsiasi, lo ritrovai a due chilometri di distanza dal luogo di incontro, in evidente stato confusionale, nemmeno fosse me in uno dei miei migliori venerdì sera. Non ho idea di cosa gli avesse detto il cervello ma aveva ben pensato di cercare il miglior bar della Brianza e questo lo avevo spinto verso lidi sconosciuti che poi non era stato in grado di localizzare perché lo raggiungessi. Ci beccammo per pura fatalità e tutto quello che portava in dote erano due panini vecchi almeno un giorno con dentro giusto la voglia di salamella.
Rammento con serenità anche quella volta che, essendo riusciti a fare tutto in good time, ci fermammo sulla strada verso casa, in autogrill. A lui presi un camogli e una redbull: prese la focaccia (ovviamente strinata fuori e fredda dentro, come da migliore tradizione degli autogrill) ma rifiutò l’energy drink perché per nulla al mondo avrebbe potuto ingrassare i bibitari della concorrenza. Geniale.
#sucarefortissimo
In Brianza andavamo sempre negli stessi posti e tra questi c’era Paullo. Inevitabile il paragone, che ad ogni viaggio mi ripeteva come un mantra, con Pavullo:”Eh, da noi c’è Pavullo, qui hanno Paullo, senza la V!”. Sembrava una reclame, una frase da umarél, il classico intermezzo da Professore di Liceo che rinforza i concetti sempre con gli stessi modi di dire.
Sarà, però alla fine era diventato un modo come un altro per farmi compagnia.
Sarà, però alla fine era diventato un modo come un altro per farmi compagnia.
Il famoso Hinterland milanese
Più di un articolo che non so a quante persone potrà effettivamente interessare, mi sembra davvero di riesumare ricordi. Anche riprendere in mano il taccuino in cui mi segnavo gli appunti di quegli anni fa uno strano effetto, quasi fosse una sorta di totem “alla Inception” e mi garantisse che, sebbene alcune stagioni della mia vita siano state seppellite nel profondo e solo descrivendo questi viaggi io riesca a rammentare particolari che credevo di aver completamente rimosso, è tutto finito e quel che conta, ciò che è reale, è ora, right here right know.
I can't let you touch it, that would defeat the purpose.
See only I know the balance and the weight of this particular loaded die.
That way, when you look at your totem, you know beyond a doubt that you're not in someone else's dream.
Per esempio nei pressi di Paullo c’era una ditta di cucine e l’omino che si occupava dello scarico, mi ribadiva ogni volta che mi vedeva che, presto o tardi, avrebbe comprato un carhartt come il mio ad una delle sue due figlie; mi chiedeva quanto costasse, se mi ci trovassi bene, se fosse di moda. Non ho idea del perché ma non riusciva a trovarlo né nelle boutique milanesi né in tutta la Brianza, non doveva essere un gran fulmine di guerra. Comunque sia, arrivò ad offrirmi quattrocento euro perché gli vendessi il mio, roba da convincersi che la natura umana possa essere profondamente variegata, ma anche che ci sono casi in cui nemmeno Darwin ci capirebbe un cazzo.
Fascino intramontabile
CASTELL’ARQUATO
Di tanto in tanto, di ritorno dalla Brianza, c’era caso mi dovessi fermare nel piacentino, dove il titolare aveva degli affari personali. Per suo conto dovevo caricare o scaricare materiale che non riguardava il lavoro. Ricordo con affettuoso piacere quella volta che dovevo effettuare un ritiro in un caseificio. Con i soldi della trasferta, quelli che, per intenderci, l’azienda mi passava per le esigenze di viaggio, allo spaccio presi due bottiglie di Gutturnio, qualche etto di culatello e un po’ di coppa. Certo, non era una buona azione ma erano gli ultimi giorni che avrei lavorato per il mio vecchio titolare, ci avevo abitato insieme abbastanza, avevo già la mezza idea di dimettermi e presto sarebbe diventata intera, per cui fu proprio mio padre ad assecondarmi e a suggerirmi di investire quei pochi contanti in un qualcosa che mi potesse rasserenare e che rappresentasse una specie di piccola vendetta obliqua.
Dio benedica voi e la vostra coppa
E tutto sommato, e forse anche per quello, fu una bella giornata di enogastronomia, e un altro significativo dettaglio derivò dal fatto che, avendo la macchina aziendale, disponessi di una radio, privilegio di cui non potevo godere quando ero alla guida dei furgoncini. Non avevo con me cd o chiavette per cui dovevo accontentarmi dei canali FM. Me li feci andare bene e quando l’accesi volevo fortemente ascoltare una determinata canzone, il tormentone di quel periodo. Ebbene, quasi girare le stazioni fosse come strofinare la lampada del genio perché venissero esauditi i miei desideri sonori, così avvenne.
Erano appena cominciati i Mondiali del 2010 che io stavo vivendo insieme ai miei amici e alle mie amiche, e c’era una canzone che rimandava a quelle emozioni, a quella leggerezza che tanto contrastava con la gravità della mia situazione lavorativa.
No, non era un capolavoro allora né lo può essere considerato ora, ma in quel momento era la perfetta colonna sonora.
Evviva evviva le gambotte della Shakira
Qualche mese fa insieme alla mia famiglia siam tornati nel piacentino e abbiamo visitato Bobbio.
Mio padre ricordava perfettamente quella trasferta a Castell'arquato come fosse ieri, ho provato una sensazione che andava al di là del piacere, una sorta di reciproca condivisione profonda.
Bobbio, una piccola perla incastonata nell'Appenino Piacentino
VENETO
Lo odiavo profondamente, il Veneto. L’ho odiato profondamente, ne avrei fatto terra bruciata. Una volta persi la trebisonda e invece di raggiungere il franco destino finii a cinquanta chilometri di distanza: fu un’avventura di uno sconforto abissale. Per riallacciare rapporti pacifici con le terre della Marca e del lontano est sarebbero passati anni, perché solo tra 2013 e 2014 son riuscito a prendere il coraggio a due mani e tornare in Veneto, con diffidente tranquillità, e rivedere quei luoghi.
La scorsa estate, al ritorno dalla Croazia, son intenzionalmente passato da Portogruaro, dove, al tempo dell’impiego presso quella piccola azienda, avevo passato qualche notte in occasione di una fiera di settore. Volevo fermarmi, ritrovare qualche ricordo e rinverdirlo. Poi ho cambiato idea e non ho nemmeno parcheggiato. La questione si definiva così. Caro Portogruaro, son tornato solo perché ci restituissimo le fotografie: possiamo archiviare la pratica, a mai più rivederci.
Peccato perché non è nemmeno 'sto paese del cazzo
ALTEDO
Tra il 2009 e il 2010 ci fu un inverno glaciale, omerico, soprannaturale, sembrava di essere dentro a Game of Thrones. Avevo appuntamento con un trasportatore cui avrei lasciato il materiale ordinato, lo avrebbe consegnato lui. Dovevamo incontrarci immediatamente fuori da un casello, tra Padova e Treviso. C’era così freddo che l’acqua dei tergicristalli si ghiacciava ancor prima d’essersi distribuita sul parabrezza: non ho mai più rivisto niente di simile. Raggiunto il luogo deputato allo scambio, il camionista ci venne incontro e, pensando che mio padre (che viaggiava, come sempre, sotto mentite spoglie) fosse un collega più vecchio di me (e per mangiare la foglia presi a chiamarlo col nome di battesimo, cosa che non avevo né avrei mai più fatto) cominciò a chiedergli specifiche del materiale e a fargli domande riguardo alla situazione lavorativa in Emilia. Lì per lì ebbi quattordici infarti tutti insieme poi riuscì a buttar la palla in corner e sperai che a questo estroverso bucaniere dell’Est non venisse mai in mente di riferire a qualcuno con quante persone si fosse incontrato all’uscita di quel maledetto casello.
Quante cose che non si sanno
Quella di Altedo potrebbe sembrare una qualsiasi uscita dell’A-13. Ciò che la rende particolare deriva dal fatto che si tratta di una frazione, facente capo al Comune di Malalbergo che deve il suo nome al malfamato albergo che in passati remoti offriva ristoro ai naviganti e ai commercianti che andavano a e venivano da Bologna. Al di là della storia di Malalbergo, è caratteristico che un casello conduca ad una frazione e non a un Comune più grande, anche perché non so quanti altri casi del genere esistano lungo le autostrade italiane. Ciò che però a rende speciale è l’associazione di idee che ne fece mio padre mentre vi transitammo a fianco.
Infatti si stupì enormemente di trovarla lungo l’autobahn che collegava Bologna a Padova, quasi fosse un’imboscata geografica, un errore della mappa. Si zittì un minuto per poi attaccare con una storia delle sue. Mi disse che quando era giovane ci furono nefasti anni in cui il Bologna FC era la squadra da battere e durante il ritiro estivo che fece seguito ad uno dei campionati vinti, lesse sulla Gazzetta che i rossoblu avrebbero disputato un’amichevole contro la squadra di Altedo. Mio padre se ne meravigliò molto perché associò a questo nome, “altedo” appunto, il Sud America. “Sai, Altedo suona un po’ come Laredo, Bienvenido a Toledo… pensavo fosse tipo in Argentina e tra me e me pensavo a quanto fossero diventati ricchi e famosi a Bologna per potersi permettere amichevoli in altri Continenti”. Non per forza storie così devono piacere, non sono stati di facebook, ma erano episodi curiosi che hanno resistito alla prova del tempo e che ricordo ancora. Le rare volte che mi è capitato di ripassare lungo quell’autostrada mi racconto sempre la piccola storia di Altedo, e vale la pena non smettere di farlo se mi fa sorridere.
Infatti si stupì enormemente di trovarla lungo l’autobahn che collegava Bologna a Padova, quasi fosse un’imboscata geografica, un errore della mappa. Si zittì un minuto per poi attaccare con una storia delle sue. Mi disse che quando era giovane ci furono nefasti anni in cui il Bologna FC era la squadra da battere e durante il ritiro estivo che fece seguito ad uno dei campionati vinti, lesse sulla Gazzetta che i rossoblu avrebbero disputato un’amichevole contro la squadra di Altedo. Mio padre se ne meravigliò molto perché associò a questo nome, “altedo” appunto, il Sud America. “Sai, Altedo suona un po’ come Laredo, Bienvenido a Toledo… pensavo fosse tipo in Argentina e tra me e me pensavo a quanto fossero diventati ricchi e famosi a Bologna per potersi permettere amichevoli in altri Continenti”. Non per forza storie così devono piacere, non sono stati di facebook, ma erano episodi curiosi che hanno resistito alla prova del tempo e che ricordo ancora. Le rare volte che mi è capitato di ripassare lungo quell’autostrada mi racconto sempre la piccola storia di Altedo, e vale la pena non smettere di farlo se mi fa sorridere.
Non smettiamo se ci fa sorridere
MARCHE
Prima che tra me e le Marche scoppiasse l'amore, sono passati e trapassati momenti di grande odio. Infatti tutte le volte che dovevo andare dalle parti di Pesaro e Fano, sapevo che non ci sarebbero stati limiti al peggio. Ogni scadenza sembrava essere bruciante: avevo i minuti contati per il carico, l'arrivo sull'A-1 e sull'A-14, il raggiungimento delle ditte presso cui scaricare il materiale e, infine, il ritorno a casa prima che il traffico si congestionasse all'altezza dei raccordi bolognesi.
Su tutti, e son stati tanti, ricordo tre episodi degni d'essere menzionati.
Una volta lasciai mio padre poco prima di arrivare in un'azienda di mobilieri. Gli dissi, come al solito, di prender qualcosa da mangiare mentre mi aspettava. Io non so come ci riuscì ma tornò con un panozzo farcito di frittata, un latte macchiato messo alla va là che va bene in un cartoccio modello Starbucks e una bottiglietta di Coca-Cola. Quando gli ricordai, come se ce ne fosse stato bisogno, che a me la frittata faceva cagare, fece uscire dal cilindro una brioche salata, cibo che, tra quelli che odio, è sempre stato in zona podio. Io credo che nemmeno un cieco, entrando in un bar, potesse combinare mangiarini così di merda tutti in un colpo solo.
Ad ogni buon conto si affezionò a quel bar e, sempre durante quel soprannaturale inverno di cui sopra, ci volle tornare. Partimmo da casa che c'erano -10°, un freddo becco, vestiti in maniera pesantissima, neanche venissimo dalle isole Svalbard. Il clima era così rigido che se n'era condizionati anche psicologicamente e per tutta la durata del viaggio non ci attentammo ad abbassare i finestrini per prendere aria o a fermarci per una sosta. C'era un freddo troppo grosso e fuori era davvero un brutto mondo.
Mettemmo il muso all'esterno solamente una volta arrivati in prossimità di quel bar. Il termometro del furgoncino diceva, con nostro immenso stupore, +12°, voleva insomma dire che, nel giro di duecentocinquanta km, c'era stata un'escursione termica di 22°: incredibile, come dire che ci fossero due stagioni di differenza. La gestrice ci squadrò e, incuriosita dai nostri abiti invernali e riconoscendo una diversa parlata dalla sua, ci chiese da dove venissimo. Fu enormemente sorpresa nello scoprire che quanto dicevano i telegiornali, ossia che al Nord stava battendo un freddo polare, fosse notizia vera. Fu quasi difficile convincerla che fosse davvero così, per lei era quasi una leggenda, se ci fosse già stato Game of Thrones, avremmo potuto dire di essere della Casa Stark che ci avrebbe creduto.
Il Nord non dimentica
Un giorno invece, e me lo ricorderò finché campo perché è il vertice del prisma di questa carrellata di ricordi, successe l'inverosimile. Stava andando tutto bene, eravamo appena usciti dal casello di Pesaro ed eravamo in discreto orario, saremmo arrivati a destinazione proprio allo scoccare della riapertura pomeridiana della ditta dove avremmo dovuto consegnare. Invece eravamo destinati a morire grassi, come si suol dire dalle nostre parti.
Montelabbate: bene ma non benissimo
Ad una certa m'accorsi di non essere più in grado di accorciare o allungare le marce, la frizione non rispondeva più, scivolava fino in fondo senza permettere al cambio di innescarsi. Nella sfiga ebbi l'immensa fortuna di trovare una piazzola di sosta immediatamente a fianco e, continuando di inerzia, vi parcheggiai.
Ci ho pensato mille volte, perché se fosse successa una cosa così in autostrada forse non avrei raccontato nulla di tutto questo a nessuno.
Era mezzogiorno e venti, ed io ero disperato.
Davanti a dove m'ero fermato c'era una ditta che avevamo servito in passato, conoscevo qualcuno e, mentre mio padre s'era impuntato nel cercare un meccanico, mi infilai dentro e chiesi informazioni su taxi, treni e qualsiasi cos'altro potesse riportarci a casa: del furgone in panne non mi fregava un cazzo, la consegna del materiale era diventata il male minore, l'unica cosa che davvero contasse era tornare e casa e riportarci anche mio padre. Raccolsi qualche appunto utile (gli smartphone non erano ancora uno strumento di utilizzo comune) e tornai nei pressi del camioncino. Telefonai in ditta, a casa, a Berta, a donna Ilenia, insomma, non sapevo cosa fare.
Poi mi si affiancò un carro attrezzi, che in quel momento mi parve come il buon samaritano sulla strada. Non avevo mai capito perchè la perifrasi "Deus ex machina" chiamasse l'ablativo, ma quando, oltre a mio padre, da quel mezzo scese anche il meccanico, mi fu tutto improvvisamente chiarissimo. Quest'ultimo salì sulla bestia ferita e dopo qualche manovra se ne scese con il verdetto finale:"S'è rotto il cavo della frizione. Portiamo il furgone nella mia officina, vado a mangiare e poi vediamo cosa riusciamo a fare. Il cavo non posso sostituirtelo perché servirebbero tre giorni solo per averlo, ma posso provare a riparartelo in un qualche modo". Gli chiesi quanto ci sarebbe voluto e lui rispose che se tutto fosse andato bene sarei potuto ripartire, ma non prima delle quattro.
Poi mi si affiancò un carro attrezzi, che in quel momento mi parve come il buon samaritano sulla strada. Non avevo mai capito perchè la perifrasi "Deus ex machina" chiamasse l'ablativo, ma quando, oltre a mio padre, da quel mezzo scese anche il meccanico, mi fu tutto improvvisamente chiarissimo. Quest'ultimo salì sulla bestia ferita e dopo qualche manovra se ne scese con il verdetto finale:"S'è rotto il cavo della frizione. Portiamo il furgone nella mia officina, vado a mangiare e poi vediamo cosa riusciamo a fare. Il cavo non posso sostituirtelo perché servirebbero tre giorni solo per averlo, ma posso provare a riparartelo in un qualche modo". Gli chiesi quanto ci sarebbe voluto e lui rispose che se tutto fosse andato bene sarei potuto ripartire, ma non prima delle quattro.
Se da un lato tirai un sospiro di sollievo perché quel santo meccanico di Gaudenzi (è l'unico nome che faccio in tutto questo racconto ma son contento di farlo perché fu davvero una brava persona, che Dio lo benedica) s'era detto in grado di aggiustare il mio mezzo, dall'altra provai a visualizzare quello che avrei dovuto fare da quel momento in poi. Avrei dovuto chiamare un tizio della ditta verso cui mi stavo dirigendo prima dell'imprevisto e chiedergli di raggiungermi all'officina, così da consegnare a lui la roba, e avrei dovuto provare a fare la stessa cosa con qualcuno dell'azienda di Fano.
Riconobbi in mio padre un incredibile animale a sangue freddo: mentre io ero andato completamente nel pallone e non sapevo più che cappello mettermi, lui aveva mantenuto una calma olimpica e, sotto traccia, stava cercando di riportare la nave fuori dalla tempesta.
C'era una volta Olsen Olsen
Dall'officina di Gaudenzi, per ritirare i suoi colli (e solo per quello), si presentò l'omino della prima ditta, un inenarrabile pezzo di merda, falso come un ladro, il quale mi disse di non esitare a chiamarlo se avessi avuto bisogno. Mentre lo guardavo dire queste parole, in sovrimpressione passava nitidamente il sottotitolo: "Credimi! Parola di Pinocchio".
L'uomo della seconda ditta disse invece di non riuscire a passare e che ci sarei potuto andare anche il lunedì successivo: gli augurai un inverno di cefalee a grappolo e mi diedi per inteso il dover andare fino a Fano, furgone e tempo permettendo, quel venerdì stesso.
Just a matter of time
Io e mio padre mangiammo e bevemmo qualcosa insieme, e, per ingannare il tempo, facemmo un giro in mezzo alla campagna che circondava l'officina di Gaudenzi: sarebbe stato l'unico momento tranquillo della giornata. Lui mi indicava le piante, me li descriveva, cercava in ogni modo di allontanare da me i cattivi pensieri che si facevano sempre più insistenti nella mia testa. Tuttavia io sentivo senza ascoltare, per me era una camminata di riflessione, stavo finalmente pianificando ciò che sarebbe stato della mia vita non appena tornato a casa. M'ero rotto il cazzo che quel coglione del mio titolare picchiasse sempre i muli che tiravano di più. Per quanto avessi mandato giù, convinto che fosse meglio leccare un osso di un bastone, ero arrivato al punto di non ritorno. M'era tutto chiaro, da quel momento in poi sarebbe cambiata ogni cosa. Sarebbe stata durissima rimanere senza lavoro, senza prospettive, ricominciare tutto da capo ma stavo anche maturando la convinzione che ce l'avrei potuta fare, che non avrei dovuto aver paura, e questo perché le persone danneggiate non ne hanno, per il semplice fatto che sanno come sopravvivere.
Il "Dottor" Gaudenzi, stando al suo stesso detto, uscì dall'officina alle quattro, comunicandomi di aver messo a posto il furgone in una qualche maniera. Mi disse che non aveva potuto sostituire il cavo della frizione ma di aver inserito un meccanismo che, sebbene stesse su con una preghiera, m'avrebbe consentito di percorrere almeno trecento km senza grosse preoccupazioni.
Lo pagai, espressi tutta la mia riconoscenza e lo venerai nemmeno fosse un Santo che m'avesse appena fatto una grazia. Ripartimmo alla volta di Fano, mio padre mi diede una pacca sulla spalla, puntualizzando che lui non aveva la mia testa ma di sicuro vantava un più sviluppato senso nel fare le cose, e raggiungemmo la seconda ditta. Facemmo tutto quello che era rimasto in sospeso e ripartimmo alla volta di casa, sperando che quel device di fortuna installato da Gaudenzi non cedesse.
Fano, addio.
LAST NIGHT GAUDENZI SAVED MY LIFE
Evidentemente, nell'esistenza di ognuno di noi sono presenti persone il cui incontro non dura più di qualche ora, eppure il loro peso specifico è incalcolabile, possono cambiare colore al cavallo della nostra vita e trasformarla completamente. Il meccanico Gaudenzi è stato una di quelle persone. Non solo mi salvò la vita a Montelabbate, rimettendomi su un furgone che, fosse stato per me, avrei lasciato arrugginisse nelle Marche, ma lo aveva aggiustato così bene che nell'interminabile colonna di Bologna (dove per un niente rischiai pure di restare senza benzina) non ebbe il minimo problema. Doveva resistere trecento km massimo e non più di tre ore di viaggio: facemmo quattrocento km e sei o sette ore di cambi costanti e repentini: non diede alcun segno di cedimento.
Ognuno di noi ha i propri enigmi
Ognuno di noi ha i propri enigmi
La storia nella storia però è un'altra. Quella sera io, per nessuna ragione al mondo, sarei potuto rimanere nelle Marche, dovevo tornare a casa ad ogni costo perché la mattina successiva sarei andato via, per la prima volta, con quella che sarebbe diventata la mia futura compagna: avrei finalmente fatto un viaggio di piacere dopo tanti, troppi, di dovere.
Può far strano ma è bello pensare che se non ci fossero stati mio padre e il meccanico Gaudenzi, forse questo non sarebbe accaduto, e se così non fosse stato, chissà quante altre cose sarebbero state differenti.
COSE SEMPLICI E BANALI
A volte si vuole ricordare perché ci piace, altre è il tentativo di storicizzare il passato e altre ancora ci si ripete le stesse cose senza motivo, alla noia, primo sintomo della vecchiaia. Vero è, però, che sono le cose semplici e banali quelle che servono per riconciliarsi con gli anni sprecati, perché sono le più importanti.
Perché sì, siamo alla fine e ho perso l'inizio, ma tutto sembra avere un senso in più.
Perché sì, siamo alla fine e ho perso l'inizio, ma tutto sembra avere un senso in più.





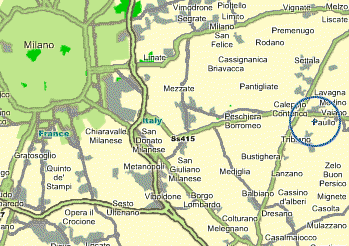











Nessun commento:
Posta un commento